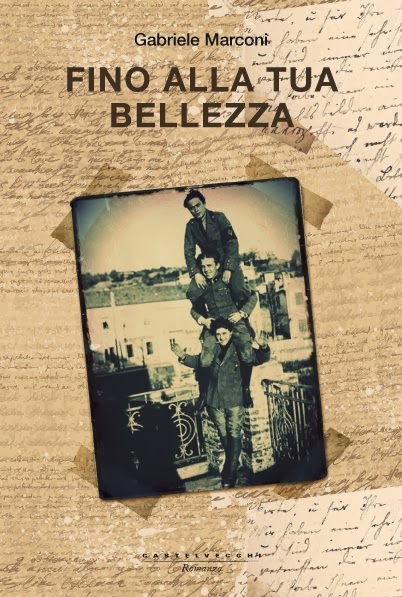lunedì 30 giugno 2008
venerdì 20 giugno 2008
IL REGNO NASCOSTO: Amico è... un Nano che vive e lotta insieme a noi!

Di Roberto Alfatti Appetiti
«L’evasione è una delle principali funzioni delle fiabe. Respingo il tono sprezzante e compassionevole che connota tanto spesso, oggi, il termine. Perché un uomo dovrebbe essere disprezzato se, trovandosi in carcere, cerca di evadere per tornare a casa? Oppure, se non lo può fare, se pensa e parla di argomenti diversi che non siano carcerieri e mura di prigione? I critici confondono l’evasione del prigioniero con la fuga del disertore». Così scrive J.R.R. Tolkien in Albero e foglia, un milione d’anni fa, nell’Era della Ideologia Totalizzante, quella – per intenderci – del confronto muscolare delle Maiuscole. Ben prima che sui grandi schermi di tutto il mondo arrivassero kolossal cinematografici tratti dalle opere del celebre scrittore inglese, seguite dalle avventure di quel maghetto libertario di Harry Potter, e che i grandi editori scoprissero il business della fantasy.Sia chiaro: non che ne Il Regno Nascosto (Dario Flaccovio Editore) – il nuovo romanzo di Gabriele Marconi e Errico Passaro, da pochissimi giorni in libreria – manchino i muscoli. Se ci macchiassimo di una tale affermazione, dovremmo vedercela con i nani. Leali finché si vuole, ma permalosi! Pronti a tirare fuori l’ascia e a sfidarci a singolar tenzone per molto meno.
Perché protagonista di questo bellissimo romanzo è il popolo dei nani, depositario di quei valori tradizionali che gli uomini – nella IV era avanzata (tolkienianamente parlando) che fa da ambientazione alla storia – hanno quasi del tutto abbandonato, “imprigionati” nelle attività commerciali. Gli elfi avevano lasciato la Terra di Mezzo, gli hobbit si erano ritirati e – parafrasando una celebre massima di Woody Allen – neanche i nani si sentivano tanto bene. Per lungo tempo avevano condiviso il mondo con gli uomini. Poi erano partiti tutti insieme per cercare un luogo adatto a ricostruire il loro regno, nel grande Nord. In pochi, ormai, abitavano nei “quartieri naneschi” delle città degli uomini: nel villaggio di Cuterbor solo Althorf del clan Maûk e i suoi nipoti, Vitur e Tekkur. E per inseguire questo luogo leggendario e riunirsi al loro popolo nascosto, i due nani si mettono in viaggio. Sul loro cammino troveranno amici inaspettati e nemici dichiarati quanto spietati in un avvincente crescendo di colpi di scena.
Sì, perché aprire il libro è come salire su una carrozza che all’improvviso si mette a correre rimbalzandoci da una parte all’altra e non è più possibile – né lo si vuole – scendere. Ci si ritrova in un mondo sconosciuto eppure familiare, soprattutto per gli appassionati delle saghe del maestro Tolkien, e quando infine si arriva a destinazione rimane quella destabilizzante e piacevole sensazione di smarrimento che la migliore narrativa lascia in dote ai lettori, ripagandoli ampiamente del tempo sottratto ad altre più utilitaristiche attività. Il piacere meraviglioso della lettura libera da pedagogismi e tesi politiche preconfezionate.Quasi sobbalza sulla sedia Gabriele Marconi, quando gli rivolgiamo le domande che uno scrittore di fantasy mai vorrebbe sentirsi fare: c’è una metafora dietro alla storia? I nani chi rappresentano? «La metafora – protesta – è nemica della fiaba vera». Ma come, c’intestardiamo, a Cannes trionfano film italiani su Andreotti e sulla camorra in un formidabile tandem di attualità estrema, e voi vi interessate al destino di un manipolo di nani?
«L’evasione è una delle principali funzioni delle fiabe. Respingo il tono sprezzante e compassionevole che connota tanto spesso, oggi, il termine. Perché un uomo dovrebbe essere disprezzato se, trovandosi in carcere, cerca di evadere per tornare a casa? Oppure, se non lo può fare, se pensa e parla di argomenti diversi che non siano carcerieri e mura di prigione? I critici confondono l’evasione del prigioniero con la fuga del disertore». Così scrive J.R.R. Tolkien in Albero e foglia, un milione d’anni fa, nell’Era della Ideologia Totalizzante, quella – per intenderci – del confronto muscolare delle Maiuscole. Ben prima che sui grandi schermi di tutto il mondo arrivassero kolossal cinematografici tratti dalle opere del celebre scrittore inglese, seguite dalle avventure di quel maghetto libertario di Harry Potter, e che i grandi editori scoprissero il business della fantasy.Sia chiaro: non che ne Il Regno Nascosto (Dario Flaccovio Editore) – il nuovo romanzo di Gabriele Marconi e Errico Passaro, da pochissimi giorni in libreria – manchino i muscoli. Se ci macchiassimo di una tale affermazione, dovremmo vedercela con i nani. Leali finché si vuole, ma permalosi! Pronti a tirare fuori l’ascia e a sfidarci a singolar tenzone per molto meno.
Perché protagonista di questo bellissimo romanzo è il popolo dei nani, depositario di quei valori tradizionali che gli uomini – nella IV era avanzata (tolkienianamente parlando) che fa da ambientazione alla storia – hanno quasi del tutto abbandonato, “imprigionati” nelle attività commerciali. Gli elfi avevano lasciato la Terra di Mezzo, gli hobbit si erano ritirati e – parafrasando una celebre massima di Woody Allen – neanche i nani si sentivano tanto bene. Per lungo tempo avevano condiviso il mondo con gli uomini. Poi erano partiti tutti insieme per cercare un luogo adatto a ricostruire il loro regno, nel grande Nord. In pochi, ormai, abitavano nei “quartieri naneschi” delle città degli uomini: nel villaggio di Cuterbor solo Althorf del clan Maûk e i suoi nipoti, Vitur e Tekkur. E per inseguire questo luogo leggendario e riunirsi al loro popolo nascosto, i due nani si mettono in viaggio. Sul loro cammino troveranno amici inaspettati e nemici dichiarati quanto spietati in un avvincente crescendo di colpi di scena.
Sì, perché aprire il libro è come salire su una carrozza che all’improvviso si mette a correre rimbalzandoci da una parte all’altra e non è più possibile – né lo si vuole – scendere. Ci si ritrova in un mondo sconosciuto eppure familiare, soprattutto per gli appassionati delle saghe del maestro Tolkien, e quando infine si arriva a destinazione rimane quella destabilizzante e piacevole sensazione di smarrimento che la migliore narrativa lascia in dote ai lettori, ripagandoli ampiamente del tempo sottratto ad altre più utilitaristiche attività. Il piacere meraviglioso della lettura libera da pedagogismi e tesi politiche preconfezionate.Quasi sobbalza sulla sedia Gabriele Marconi, quando gli rivolgiamo le domande che uno scrittore di fantasy mai vorrebbe sentirsi fare: c’è una metafora dietro alla storia? I nani chi rappresentano? «La metafora – protesta – è nemica della fiaba vera». Ma come, c’intestardiamo, a Cannes trionfano film italiani su Andreotti e sulla camorra in un formidabile tandem di attualità estrema, e voi vi interessate al destino di un manipolo di nani?
 La domanda appare ancora più provocatoria se si pensa che Gabriele Marconi, oltre che scrittore affermato – autore tra l’altro di Io non scordo (Settimo Sigillo, 1999, riedito da Fazi nel 2004) – è anche direttore responsabile di Area, una rivista politica tutt’altro che “neutrale” nel dibattito politico-culturale.
La domanda appare ancora più provocatoria se si pensa che Gabriele Marconi, oltre che scrittore affermato – autore tra l’altro di Io non scordo (Settimo Sigillo, 1999, riedito da Fazi nel 2004) – è anche direttore responsabile di Area, una rivista politica tutt’altro che “neutrale” nel dibattito politico-culturale.«Tra le righe del romanzo – confessa – ci sono le mie esperienze della politica fatta per strada, le amicizie nate in contesti politicamente più difficili di quelli odierni, ma è bene che i narratori si facciano da parte per lasciare alla storia la possibilità di evolversi in piena libertà».
«Non scriveremmo di nani e draghi, sarebbe riduttivo – aggiunge Errico Passaro, giornalista e scrittore con all’attivo cinque romanzi e un centinaio di racconti, tra i massimi esperti in materia di fantastico – se non pensassimo di proporre modelli di comportamento esemplari attraverso i comportamenti concludenti dei protagonisti che, affrontando le situazioni di pericolo, mettono in scena precisi canoni morali ed etici. Non è, il nostro, un manifesto funzionale a dettare tavole dei valori né tanto meno una predica – come usa fare certa narrativa contemporanea – ma di sicuro indichiamo una precisa scelta di campo: l’egoismo cede il passo all’altruismo e l’individualismo allo spirito comunitario. Nella battaglia non puoi essere solo, devi legarti a una compagnia e dare il meglio di te, senza cedimenti».
E che l’unione faccia la forza lo dimostra anche l’ottimo “risultato” di questa opera a quattro mani, resa senza ricerche letterarie pretenziose e con uno stile semplice e diretto che la rende accessibile anche a un pubblico di giovani. Scritta – tra l’altro – da un Marconi giovanissimo: «La storia era custodita, sia pure in fase embrionale – racconta – in un’agenda di oltre vent’anni fa. È la prima cosa che ho buttato giù, solo molto tempo dopo ho iniziato a raccontarla come favola a mia figlia». Più recentemente è nata l’idea di riprenderla e svilupparla grazie al contributo di Passaro, uno scrittore dalle caratteristiche molto diverse ma con un minimo comune denominatore molto forte, l’amore per Tolkien, al quale il romanzo è un omaggio dichiarato. Una passione che viene da lontano. «Negli anni Settanta i romanzi di Tolkien – ricorda Marconi – sconvolsero la dittatura del realismo imposta dal conformismo di allora, quando solo a parlare di fantasia si veniva banditi come fascisti. E a Tolkien venne riservato lo stesso trattamento, malgrado le arrampicate sugli specchi di quanti oggi smentiscono i propri scritti di quel periodo. Sia Il Signore degli anelli che Lo hobbit furono come una ventata d'aria pura e libera dopo i fumi che appestavano la nostra atmosfera».
«Non si tratta di un romanzo con pretenziose connotazioni etiche – sottolinea Passaro – ed è diverso da quanto scriviamo singolarmente. Quanto realizzato è l’alchimia tra la mia anima roboante e retorica e quella giullaresca e cameratesca di Gabriele. Non manca una forte componente eroica ma niente di marziale. È soprattutto un romanzo sul valore dell’amicizia». E l’amicizia tra Marconi e Passaro è nata proprio al premio Tolkien, nella cui edizione del 1988 Marconi arrivò in finale con la sua opera d’esordio, il racconto Il guardiano.
E i personaggi e le vicende dei libri di Tolkien sono evocate soprattutto nelle canzoni contenute ne Il Regno Nascosto – tre scritte da Marconi e una, Tramonti, da Francesco Mancinelli – cui spetta, come vuole la tradizione, il ruolo di narrare e tramandare le storie antiche. È proprio dopo aver ascoltato le leggende sul regno dei nani e sulla potenza della loro gente che Vitur e Tekkur decidono di partire, costi quel che costi.
 E non è certo un caso se la presentazione del libro – organizzata per questa sera alle ore 18 presso la Biblioteca Angelica in piazza Sant’Agostino a Roma, con la presenza, oltre che degli autori, di Gianfranco de Turris e Gianluca Teodori di Radio Dimensione Suono – sarà arricchita da un breve concerto acustico del gruppo La Contea in cui saranno cantate proprio le canzoni presenti nel libro, grazie alle quali chi avrà la fortuna di parteciparvi potrà immergersi sin da subito in quel respiro multitemporale che rappresenta la caratteristica principale della letteratura “di fantasia”: quando la circolarità del tempo allarga l’orizzonte del lettore verso dimensioni altre rispetto al presente. È questa, in definitiva, la chiave del successo di quella che fino a non molti anni fa veniva liquidata come narrativa di “genere”: la capacità di parlare alle giovani generazioni, di proporre valori altri in una società moderna in cui mancano sempre più punti di riferimento etici e gli unici ruoli disponibili – nel grande mercato culturale – sono quelli di produttore e consumatore (passivo) di beni e servizi. E di libri. Senza l’auspicabile vera terza via, quella del sogno, dell’azione esemplare, dell’evasione liberatoria da un presente nel quale – a differenza del fantasy, dove le “brutture” vengono affrontate a viso aperto – non è chiara la linea di confine tra bene e male e le persone raramente riescono a emergere per quel che sono e valgono.
E non è certo un caso se la presentazione del libro – organizzata per questa sera alle ore 18 presso la Biblioteca Angelica in piazza Sant’Agostino a Roma, con la presenza, oltre che degli autori, di Gianfranco de Turris e Gianluca Teodori di Radio Dimensione Suono – sarà arricchita da un breve concerto acustico del gruppo La Contea in cui saranno cantate proprio le canzoni presenti nel libro, grazie alle quali chi avrà la fortuna di parteciparvi potrà immergersi sin da subito in quel respiro multitemporale che rappresenta la caratteristica principale della letteratura “di fantasia”: quando la circolarità del tempo allarga l’orizzonte del lettore verso dimensioni altre rispetto al presente. È questa, in definitiva, la chiave del successo di quella che fino a non molti anni fa veniva liquidata come narrativa di “genere”: la capacità di parlare alle giovani generazioni, di proporre valori altri in una società moderna in cui mancano sempre più punti di riferimento etici e gli unici ruoli disponibili – nel grande mercato culturale – sono quelli di produttore e consumatore (passivo) di beni e servizi. E di libri. Senza l’auspicabile vera terza via, quella del sogno, dell’azione esemplare, dell’evasione liberatoria da un presente nel quale – a differenza del fantasy, dove le “brutture” vengono affrontate a viso aperto – non è chiara la linea di confine tra bene e male e le persone raramente riescono a emergere per quel che sono e valgono.E allora non rimane – per chi non potrà partecipare all’iniziativa romana di oggi – che leggere il libro e goderne la leggerezza ma anche la densità. Aspettando il seguito che – ci anticipa Passaro – «potrebbe essere... dietro l’angolo».
(dal Secolo d'Italia di venerdì 13 giugno 2008)
martedì 10 giugno 2008
BOTTA & RISPOSTA - Ma dov’è la grande narrativa?
di Marco Cimmino e Gabriele Marconi
 Così, al dì d’ancuo, i cosiddetti bestseller hanno tutti lo stesso formato: carta grossa, caratteri ben leggibili, rilegatura pesante e cinquecento pagine. Poco importa se contengono una storia che Maupassant avrebbe inserito nei suoi Contes, che di pagine ne fanno trecento, con trenta idee diverse e trenta racconti indipendenti uno dall’altro: oggi Maupassant scriverebbe un quinto e guadagnerebbe dieci volte di più. Oppure si tirerebbe un colpo, più probabilmente. E, leggendo Follet o Forsyth o un altro di quelli con un cognome da banca d’affari di Manhattan, il lettore prova, inevitabilmente, la sensazione di una pletora di descrizioni minute: un uragano di particolari poco significativi diluiscono la trama, l’intreccio e l’azione. Per raggiungere le fatidiche cinquecento, maledette, pagine. Alla fine del romanzo, rimane l’impressione di una bella storia, magari ben costruita, ma che si poteva raccontare in tre, quattro colpi di scena, al massimo. E che i deuteragonisti potevano essere tre, quattro: non venticinque, di cui venti scompaiono senza interferire incisivamente con la vicenda. O forse, questo pare a me, perchè affronto la pagina bianca maniacalmente: la vedo come un pentagramma, in cui solo l’accostamento esatto tra le note può dare origine ad armoniosi accordi e non a grottesche cacofonie. Ogni singola parola, ogni aggettivo che si accoppia col suo sostantivo, appare ai miei occhi come un frammento di un gigantesco mosaico: e solo una è la tessera che, per colore e per forma, si adatta perfettamente ad un’altra.
Così, al dì d’ancuo, i cosiddetti bestseller hanno tutti lo stesso formato: carta grossa, caratteri ben leggibili, rilegatura pesante e cinquecento pagine. Poco importa se contengono una storia che Maupassant avrebbe inserito nei suoi Contes, che di pagine ne fanno trecento, con trenta idee diverse e trenta racconti indipendenti uno dall’altro: oggi Maupassant scriverebbe un quinto e guadagnerebbe dieci volte di più. Oppure si tirerebbe un colpo, più probabilmente. E, leggendo Follet o Forsyth o un altro di quelli con un cognome da banca d’affari di Manhattan, il lettore prova, inevitabilmente, la sensazione di una pletora di descrizioni minute: un uragano di particolari poco significativi diluiscono la trama, l’intreccio e l’azione. Per raggiungere le fatidiche cinquecento, maledette, pagine. Alla fine del romanzo, rimane l’impressione di una bella storia, magari ben costruita, ma che si poteva raccontare in tre, quattro colpi di scena, al massimo. E che i deuteragonisti potevano essere tre, quattro: non venticinque, di cui venti scompaiono senza interferire incisivamente con la vicenda. O forse, questo pare a me, perchè affronto la pagina bianca maniacalmente: la vedo come un pentagramma, in cui solo l’accostamento esatto tra le note può dare origine ad armoniosi accordi e non a grottesche cacofonie. Ogni singola parola, ogni aggettivo che si accoppia col suo sostantivo, appare ai miei occhi come un frammento di un gigantesco mosaico: e solo una è la tessera che, per colore e per forma, si adatta perfettamente ad un’altra.
Questo mi ha sempre portato a detestare le epoche letterarie votate al contenuto: all’idea che prevale sulla forma. Le epoche magnificamente educative della letteratura mi hanno sempre fatto recere, sia detto tra noi: il Romanticismo, il Neorealismo, mi lasciano la stessa impressione di questa desolata letteratura contemporanea, che non racconta nulla e, per di più, non insegna nulla.
Lo so che esagero, come al solito. Ma, siccome queste righe, oltre a te, che mi conosci come le tue tasche, devono leggerle anche i nostri ventidue lettori (uno meno di Guareschi), voglio essere esageratamente esplicito.
È ovvio che non mi sogno di negare il valore di una letteratura densa di contenuti, siano essi valoriali come estetici: quel che voglio dire è che, se al posto dell’arte o dell’ottimo artigianato, si introduce il taylorismo nella creazione letteraria, la letteratura va a remengo. Insomma: non basta avere delle idee o delle visioni. Bisogna anche conoscere meticolosamente le regole della produzione formale: perchè in un’opera d’arte forma e contenuto si equivalgono e, anzi, spesso coincidono. Io preferisco una pagina, apparentemente non narrativa, scritta nel pirotecnico barocco di Gadda, a tutto Vittorini. Incornicerei con l’alloro e l’ulivo un’ipotiposi di Buzzati, laddove adibirei alla pattumiera tutto Baricco.
 Questo e non altro voglio significare: che viviamo in tempi in cui l’orgia della comunicazione impone di scrivere e di raccontare. Ma gli strumenti latitano: i talenti languono. Lo stile manca. E manca perchè è proprio la forma, paradossalmente, l’elemento della scrittura che più risente della decadenza dei costumi: è la forma che necessita di tradizione e di scuola, di faticosa e lunga applicazione. La nemica è la fretta: la necessità di scrivere tanto e di venderlo subito. Tanto è vero che il tuo romanzo, formalmente più bello, è quello che più fatica a trovare sbocchi editoriali: il che non è affatto casuale.
Questo e non altro voglio significare: che viviamo in tempi in cui l’orgia della comunicazione impone di scrivere e di raccontare. Ma gli strumenti latitano: i talenti languono. Lo stile manca. E manca perchè è proprio la forma, paradossalmente, l’elemento della scrittura che più risente della decadenza dei costumi: è la forma che necessita di tradizione e di scuola, di faticosa e lunga applicazione. La nemica è la fretta: la necessità di scrivere tanto e di venderlo subito. Tanto è vero che il tuo romanzo, formalmente più bello, è quello che più fatica a trovare sbocchi editoriali: il che non è affatto casuale.
Dammi retta, Gabriele: lo so che il lampo creativo affascina di più. Il vero demiurgo, però, quello che rimane nel tempo, non può che prendere le mosse dai caratteri più accademicamente formali, per inventare uno stile nuovo e sicuro. Il suo: che dopo qualche secolo diverrà, a sua volta, accademia. Chi si ricorderà, fra trent’anni, di Baricco?
At zalùt.
 Sarà pur vero che Stephen King è un autore fluviale che alluviona prima di arrivare al mare, ma la sua è tutta acqua che fa girare ruote di mulino: sono ben poche le gocce che vanno sprecate. Passaggi apparentemente inutili che riempiono pagine intere (apparentemente emendabili) tornano infine a incastrarsi in quel mosaico di cui anche tu parli, così da riempire spazi altrimenti irraggiungibili.
Sarà pur vero che Stephen King è un autore fluviale che alluviona prima di arrivare al mare, ma la sua è tutta acqua che fa girare ruote di mulino: sono ben poche le gocce che vanno sprecate. Passaggi apparentemente inutili che riempiono pagine intere (apparentemente emendabili) tornano infine a incastrarsi in quel mosaico di cui anche tu parli, così da riempire spazi altrimenti irraggiungibili.
Prendi It: milleduecentotrentotto pagine, un mattone grosso così che rileggo periodicamente. Perché? Intanto perché mi piace tanto e già tanto basta. Ma soprattutto perché è scritto talmente bene che riesce a farti dimenticare che stai leggendo. Perché ci sono stili che soltanto a una lettura distratta possono apparire facili… ci sono leggerezze che, viceversa, sono raggiungibili solo attraverso uno studio matto. Ci sono modi di scrivere - per parlar chiari - che sulla pagina non lasciano orme, né tracce, né ditate… nessun segnale, insomma, che rimanga lì a dirti “Ehi, guarda che roba! Sono o non sono un grande scrittore?”.
 Dici delle descrizioni minute dei vari Follet o Forsyte, ma mi hai forse mai sentito parlar di loro o visto leggere un romanzo di uno dei due? Quella è la narrativa un tanto al chilo di cui parli. Ma non è il caso di King o - per fare un altro nome - di Dennis Lehane. Ebbene sì, ho citato un altro yankee. Ma l’uno e l’altro hanno una lucidità, nell’osservare il Sogno Americano, che li avvicina a noi più di quanto possa apparire in prima battuta. Perché mostrandoci la dolce provincia americana, tra skate, pop corn, cinema e viali alberati, riescono addirittura a farci sognare quei luoghi. Ma poi, dietro il sipario di quell’America dorata, svelano i mille piccoli mali quotidiani che infangano quell’oro… E il bello è che non trasformano il sogno in un incubo vischioso: la bellezza resta, ma è proprio questo che rende infinitamente più spaventosi gli angoli bui che, forse, altrove sarebbero meno oscuri, magari solo per minor contrasto. È quando, come avverte Antonio Faeti, «si scopre che l’inferno e il paradiso appartengono allo stesso condominio». È quella stessa “America amara” di cui parlavano Emilio Cecchi e gli altri giovani intellettuali fascisti degli anni Trenta.
Dici delle descrizioni minute dei vari Follet o Forsyte, ma mi hai forse mai sentito parlar di loro o visto leggere un romanzo di uno dei due? Quella è la narrativa un tanto al chilo di cui parli. Ma non è il caso di King o - per fare un altro nome - di Dennis Lehane. Ebbene sì, ho citato un altro yankee. Ma l’uno e l’altro hanno una lucidità, nell’osservare il Sogno Americano, che li avvicina a noi più di quanto possa apparire in prima battuta. Perché mostrandoci la dolce provincia americana, tra skate, pop corn, cinema e viali alberati, riescono addirittura a farci sognare quei luoghi. Ma poi, dietro il sipario di quell’America dorata, svelano i mille piccoli mali quotidiani che infangano quell’oro… E il bello è che non trasformano il sogno in un incubo vischioso: la bellezza resta, ma è proprio questo che rende infinitamente più spaventosi gli angoli bui che, forse, altrove sarebbero meno oscuri, magari solo per minor contrasto. È quando, come avverte Antonio Faeti, «si scopre che l’inferno e il paradiso appartengono allo stesso condominio». È quella stessa “America amara” di cui parlavano Emilio Cecchi e gli altri giovani intellettuali fascisti degli anni Trenta.
Romanzi di questo tipo, io sono felice di leggerli, mentre le storie dei tuoi Gadda e compagnia cantante sono corse a ostacoli, gymkane da superare con le scarpe affondate nel fango… Ma non perché uno non capisce: il fatto è che ti accorgi di leggere frasi scritte da qualcuno. Bada bene: lo stesso fastidio lo provo quando una bella storia viene scritta con i piedi! Perché qui non si tratta di scegliere tra scrivere bene una storia così così o inventare una storia bellissima scrivendola male… Ma scrivere bene non significa fare i narcisi per specchiarsi in ogni pagina: lo scrittore deve saper scomparire. Solo così gli accordi diventano la musica di cui parlavi, altrimenti l’armonia viene sacrificata al virtuosismo.
Parli di Tolkien come esempio di grandezza stilistica… ma il punto è proprio questo: nelle storie come Il Signore degli Anelli ti ci puoi immergere e dimenticare che dietro tutte quelle parole una in fila all’altra c’è un autore che le ha messe insieme. Con scrittori come lui, la purezza della forma risuona senza salire sul palcoscenico, è… come dire… un’orchestra che suona Rhapsody in Blue mentre Gary Cooper prende per mano Barbara Stanwyck, ma la musica che riempie la scena è in sottofondo e tu aspetti soltanto che lui baci lei. Punto. Lo stile raffinato di Tolkien rende la storia più credibile, certo, ma non ti soffermi a dire “mamma santa, quanto scrive bene!”, perché l’unica cosa che vuoi è andare avanti nell’avventura insieme a Frodo & C.
Insomma, come diceva Nils Liedholm, la padronanza dei fondamentali è necessaria, ma te lo ricordi Chiarugi? Era un fenomeno del dribbling, però finiva quasi sempre per attorcigliarsi su se stesso e perdeva la palla. Per restare nell’allegoria calcistica, Totti è stilisticamente eccellente, ma più di tanti altri fenomeni ha proprio quel “lampo creativo” che gli consente di stare una spanna sopra gli altri e fare della sua squadra uno squadrone.
E no, caro Gabriele: ad avere belle idee sono capaci tutti. Così come ad immaginare strutture ardite, come cattedrali di paragrafi e di capitoli, non ci vuole più l’ingegno ardito dell’Alighieri, ma basta un ingegnere.
Oggi, purtroppo, il romanzo ha perduto la sua caratteristica di artigianale levigatura: oggi si scrive in serie e i romanzi sembrano sempre più quei polli in batteria, che vengono lasciati razzolare nell’aia soltanto quando qualche vecchiardo con l’uzzolo delle pubblicità decida di dare l’idea del volatile ruspante al consumatore ingiulebbato, facendosi ritrarre tra bambini deficienti e galline starnazzanti. Ma la letteratura, quella vera, è bella e morta, mio caro: oggi prosperano i Ken Follett, gli Stephen King in sedicesimo. E giacchè proprio King è uno dei tuoi prediletti, prenderò proprio lui per farti un esempio.
Stephen King è certamente un visionario di prim’ordine: un eccezionale creatore di idee narrative. È anche, va detto, un bravo scrittore: uno che conosce come pochi il mestiere di scrivere. Purtroppo, però, ha due difetti immedicabili: è americano e vive in quest’epoca americanissima. Quindi, proprio lui che, ne sono certo, disprezza la macchina editoriale statunitense, basata sul marketing, sui ghostwriter, sulle pubbliche relazioni, sui reading, è il padre della moderna ricetta letteraria: un genio al servizio della mediocrità, verrebbe da dire. Infatti, King è stato il primo o, perlomeno, il primo di fama mondiale, ad applicare il lievito alla scrittura: ogni sua idea, da cui avrebbe potuto uscire un bellissimo racconto, agile e scarno, oppure un romanzo breve, di quelli che ti tengono legato alla sedia per ore, è stata dilatata, gonfiata, amplificata, utilizzando tutti i più vieti stilemi della retorica ciceroniana. L’operazione è servita a fare assumere ad una “fabula” adatta alle cento paginette la dimensione, ideale per il mercato americano, di Guerra e Pace: il tipico mattone da cinquecento pagine, di quelli che si portano in vacanza o che si leggono a piccoli bocconi prima di addormentarsi. Una volta si chiamavano, per questo, livres de chèvet.
Oggi, purtroppo, il romanzo ha perduto la sua caratteristica di artigianale levigatura: oggi si scrive in serie e i romanzi sembrano sempre più quei polli in batteria, che vengono lasciati razzolare nell’aia soltanto quando qualche vecchiardo con l’uzzolo delle pubblicità decida di dare l’idea del volatile ruspante al consumatore ingiulebbato, facendosi ritrarre tra bambini deficienti e galline starnazzanti. Ma la letteratura, quella vera, è bella e morta, mio caro: oggi prosperano i Ken Follett, gli Stephen King in sedicesimo. E giacchè proprio King è uno dei tuoi prediletti, prenderò proprio lui per farti un esempio.
Stephen King è certamente un visionario di prim’ordine: un eccezionale creatore di idee narrative. È anche, va detto, un bravo scrittore: uno che conosce come pochi il mestiere di scrivere. Purtroppo, però, ha due difetti immedicabili: è americano e vive in quest’epoca americanissima. Quindi, proprio lui che, ne sono certo, disprezza la macchina editoriale statunitense, basata sul marketing, sui ghostwriter, sulle pubbliche relazioni, sui reading, è il padre della moderna ricetta letteraria: un genio al servizio della mediocrità, verrebbe da dire. Infatti, King è stato il primo o, perlomeno, il primo di fama mondiale, ad applicare il lievito alla scrittura: ogni sua idea, da cui avrebbe potuto uscire un bellissimo racconto, agile e scarno, oppure un romanzo breve, di quelli che ti tengono legato alla sedia per ore, è stata dilatata, gonfiata, amplificata, utilizzando tutti i più vieti stilemi della retorica ciceroniana. L’operazione è servita a fare assumere ad una “fabula” adatta alle cento paginette la dimensione, ideale per il mercato americano, di Guerra e Pace: il tipico mattone da cinquecento pagine, di quelli che si portano in vacanza o che si leggono a piccoli bocconi prima di addormentarsi. Una volta si chiamavano, per questo, livres de chèvet.
 Così, al dì d’ancuo, i cosiddetti bestseller hanno tutti lo stesso formato: carta grossa, caratteri ben leggibili, rilegatura pesante e cinquecento pagine. Poco importa se contengono una storia che Maupassant avrebbe inserito nei suoi Contes, che di pagine ne fanno trecento, con trenta idee diverse e trenta racconti indipendenti uno dall’altro: oggi Maupassant scriverebbe un quinto e guadagnerebbe dieci volte di più. Oppure si tirerebbe un colpo, più probabilmente. E, leggendo Follet o Forsyth o un altro di quelli con un cognome da banca d’affari di Manhattan, il lettore prova, inevitabilmente, la sensazione di una pletora di descrizioni minute: un uragano di particolari poco significativi diluiscono la trama, l’intreccio e l’azione. Per raggiungere le fatidiche cinquecento, maledette, pagine. Alla fine del romanzo, rimane l’impressione di una bella storia, magari ben costruita, ma che si poteva raccontare in tre, quattro colpi di scena, al massimo. E che i deuteragonisti potevano essere tre, quattro: non venticinque, di cui venti scompaiono senza interferire incisivamente con la vicenda. O forse, questo pare a me, perchè affronto la pagina bianca maniacalmente: la vedo come un pentagramma, in cui solo l’accostamento esatto tra le note può dare origine ad armoniosi accordi e non a grottesche cacofonie. Ogni singola parola, ogni aggettivo che si accoppia col suo sostantivo, appare ai miei occhi come un frammento di un gigantesco mosaico: e solo una è la tessera che, per colore e per forma, si adatta perfettamente ad un’altra.
Così, al dì d’ancuo, i cosiddetti bestseller hanno tutti lo stesso formato: carta grossa, caratteri ben leggibili, rilegatura pesante e cinquecento pagine. Poco importa se contengono una storia che Maupassant avrebbe inserito nei suoi Contes, che di pagine ne fanno trecento, con trenta idee diverse e trenta racconti indipendenti uno dall’altro: oggi Maupassant scriverebbe un quinto e guadagnerebbe dieci volte di più. Oppure si tirerebbe un colpo, più probabilmente. E, leggendo Follet o Forsyth o un altro di quelli con un cognome da banca d’affari di Manhattan, il lettore prova, inevitabilmente, la sensazione di una pletora di descrizioni minute: un uragano di particolari poco significativi diluiscono la trama, l’intreccio e l’azione. Per raggiungere le fatidiche cinquecento, maledette, pagine. Alla fine del romanzo, rimane l’impressione di una bella storia, magari ben costruita, ma che si poteva raccontare in tre, quattro colpi di scena, al massimo. E che i deuteragonisti potevano essere tre, quattro: non venticinque, di cui venti scompaiono senza interferire incisivamente con la vicenda. O forse, questo pare a me, perchè affronto la pagina bianca maniacalmente: la vedo come un pentagramma, in cui solo l’accostamento esatto tra le note può dare origine ad armoniosi accordi e non a grottesche cacofonie. Ogni singola parola, ogni aggettivo che si accoppia col suo sostantivo, appare ai miei occhi come un frammento di un gigantesco mosaico: e solo una è la tessera che, per colore e per forma, si adatta perfettamente ad un’altra.Questo mi ha sempre portato a detestare le epoche letterarie votate al contenuto: all’idea che prevale sulla forma. Le epoche magnificamente educative della letteratura mi hanno sempre fatto recere, sia detto tra noi: il Romanticismo, il Neorealismo, mi lasciano la stessa impressione di questa desolata letteratura contemporanea, che non racconta nulla e, per di più, non insegna nulla.
Lo so che esagero, come al solito. Ma, siccome queste righe, oltre a te, che mi conosci come le tue tasche, devono leggerle anche i nostri ventidue lettori (uno meno di Guareschi), voglio essere esageratamente esplicito.

È ovvio che non mi sogno di negare il valore di una letteratura densa di contenuti, siano essi valoriali come estetici: quel che voglio dire è che, se al posto dell’arte o dell’ottimo artigianato, si introduce il taylorismo nella creazione letteraria, la letteratura va a remengo. Insomma: non basta avere delle idee o delle visioni. Bisogna anche conoscere meticolosamente le regole della produzione formale: perchè in un’opera d’arte forma e contenuto si equivalgono e, anzi, spesso coincidono. Io preferisco una pagina, apparentemente non narrativa, scritta nel pirotecnico barocco di Gadda, a tutto Vittorini. Incornicerei con l’alloro e l’ulivo un’ipotiposi di Buzzati, laddove adibirei alla pattumiera tutto Baricco.
Perché è vero che senza idee non si scrivono romanzi, ma è ancora più vero che senza stile non si fa dell’arte, ma solo della scrittura. Guarda Tolkien, per prenderne uno che, rara avis, piace ad entrambi: pensa a cosa sarebbero le saghe tolkieniane scritte con lo stile delle sceneggiature dei Puffi! Pensa a quanti imitatori patetici, a quanti inadeguati raccontatori di favolette pseudoceltiche, similmedievali, fintoarcane, affliggono ed affollano le librerie, con le loro spade magiche, i loro segreti, i draghi e gli elfi: cosa crea quella vertiginosa sensazione di minorità che li divide dal maestro de Il Signore degli Anelli se non la mancanza di una formidabile volontà stilistica?
 Questo e non altro voglio significare: che viviamo in tempi in cui l’orgia della comunicazione impone di scrivere e di raccontare. Ma gli strumenti latitano: i talenti languono. Lo stile manca. E manca perchè è proprio la forma, paradossalmente, l’elemento della scrittura che più risente della decadenza dei costumi: è la forma che necessita di tradizione e di scuola, di faticosa e lunga applicazione. La nemica è la fretta: la necessità di scrivere tanto e di venderlo subito. Tanto è vero che il tuo romanzo, formalmente più bello, è quello che più fatica a trovare sbocchi editoriali: il che non è affatto casuale.
Questo e non altro voglio significare: che viviamo in tempi in cui l’orgia della comunicazione impone di scrivere e di raccontare. Ma gli strumenti latitano: i talenti languono. Lo stile manca. E manca perchè è proprio la forma, paradossalmente, l’elemento della scrittura che più risente della decadenza dei costumi: è la forma che necessita di tradizione e di scuola, di faticosa e lunga applicazione. La nemica è la fretta: la necessità di scrivere tanto e di venderlo subito. Tanto è vero che il tuo romanzo, formalmente più bello, è quello che più fatica a trovare sbocchi editoriali: il che non è affatto casuale.Dammi retta, Gabriele: lo so che il lampo creativo affascina di più. Il vero demiurgo, però, quello che rimane nel tempo, non può che prendere le mosse dai caratteri più accademicamente formali, per inventare uno stile nuovo e sicuro. Il suo: che dopo qualche secolo diverrà, a sua volta, accademia. Chi si ricorderà, fra trent’anni, di Baricco?
At zalùt.
Marco
E no, caro Marco: i grandi narratori lasciano parlare l’avventura. È la storia, ragazzi! Non quei litri d’inchiostro con cui si sbrodolano tanti scrittori che usano la forma romanzo per farci la morale (o, va da sé, l’antimorale) e ci ammanniscono quei tomi illeggibili che piacciono tanto ai Re-censori. Quando apro un libro, invece, io voglio salire in carrozza e scendere solo quando ho finito l’ultima riga… sai, quando alzi gli occhi dalla pagina e, per qualche meraviglioso istante, ti guardi attorno senza capire dove sei? Ecco, questo voglio da un romanzo. Perché dovrei tafazzarmi con (sia pur poche) pagine di una trama scelta a bella posta per mostrare un bello scrivere?
 Sarà pur vero che Stephen King è un autore fluviale che alluviona prima di arrivare al mare, ma la sua è tutta acqua che fa girare ruote di mulino: sono ben poche le gocce che vanno sprecate. Passaggi apparentemente inutili che riempiono pagine intere (apparentemente emendabili) tornano infine a incastrarsi in quel mosaico di cui anche tu parli, così da riempire spazi altrimenti irraggiungibili.
Sarà pur vero che Stephen King è un autore fluviale che alluviona prima di arrivare al mare, ma la sua è tutta acqua che fa girare ruote di mulino: sono ben poche le gocce che vanno sprecate. Passaggi apparentemente inutili che riempiono pagine intere (apparentemente emendabili) tornano infine a incastrarsi in quel mosaico di cui anche tu parli, così da riempire spazi altrimenti irraggiungibili.Prendi It: milleduecentotrentotto pagine, un mattone grosso così che rileggo periodicamente. Perché? Intanto perché mi piace tanto e già tanto basta. Ma soprattutto perché è scritto talmente bene che riesce a farti dimenticare che stai leggendo. Perché ci sono stili che soltanto a una lettura distratta possono apparire facili… ci sono leggerezze che, viceversa, sono raggiungibili solo attraverso uno studio matto. Ci sono modi di scrivere - per parlar chiari - che sulla pagina non lasciano orme, né tracce, né ditate… nessun segnale, insomma, che rimanga lì a dirti “Ehi, guarda che roba! Sono o non sono un grande scrittore?”.
 Dici delle descrizioni minute dei vari Follet o Forsyte, ma mi hai forse mai sentito parlar di loro o visto leggere un romanzo di uno dei due? Quella è la narrativa un tanto al chilo di cui parli. Ma non è il caso di King o - per fare un altro nome - di Dennis Lehane. Ebbene sì, ho citato un altro yankee. Ma l’uno e l’altro hanno una lucidità, nell’osservare il Sogno Americano, che li avvicina a noi più di quanto possa apparire in prima battuta. Perché mostrandoci la dolce provincia americana, tra skate, pop corn, cinema e viali alberati, riescono addirittura a farci sognare quei luoghi. Ma poi, dietro il sipario di quell’America dorata, svelano i mille piccoli mali quotidiani che infangano quell’oro… E il bello è che non trasformano il sogno in un incubo vischioso: la bellezza resta, ma è proprio questo che rende infinitamente più spaventosi gli angoli bui che, forse, altrove sarebbero meno oscuri, magari solo per minor contrasto. È quando, come avverte Antonio Faeti, «si scopre che l’inferno e il paradiso appartengono allo stesso condominio». È quella stessa “America amara” di cui parlavano Emilio Cecchi e gli altri giovani intellettuali fascisti degli anni Trenta.
Dici delle descrizioni minute dei vari Follet o Forsyte, ma mi hai forse mai sentito parlar di loro o visto leggere un romanzo di uno dei due? Quella è la narrativa un tanto al chilo di cui parli. Ma non è il caso di King o - per fare un altro nome - di Dennis Lehane. Ebbene sì, ho citato un altro yankee. Ma l’uno e l’altro hanno una lucidità, nell’osservare il Sogno Americano, che li avvicina a noi più di quanto possa apparire in prima battuta. Perché mostrandoci la dolce provincia americana, tra skate, pop corn, cinema e viali alberati, riescono addirittura a farci sognare quei luoghi. Ma poi, dietro il sipario di quell’America dorata, svelano i mille piccoli mali quotidiani che infangano quell’oro… E il bello è che non trasformano il sogno in un incubo vischioso: la bellezza resta, ma è proprio questo che rende infinitamente più spaventosi gli angoli bui che, forse, altrove sarebbero meno oscuri, magari solo per minor contrasto. È quando, come avverte Antonio Faeti, «si scopre che l’inferno e il paradiso appartengono allo stesso condominio». È quella stessa “America amara” di cui parlavano Emilio Cecchi e gli altri giovani intellettuali fascisti degli anni Trenta.Romanzi di questo tipo, io sono felice di leggerli, mentre le storie dei tuoi Gadda e compagnia cantante sono corse a ostacoli, gymkane da superare con le scarpe affondate nel fango… Ma non perché uno non capisce: il fatto è che ti accorgi di leggere frasi scritte da qualcuno. Bada bene: lo stesso fastidio lo provo quando una bella storia viene scritta con i piedi! Perché qui non si tratta di scegliere tra scrivere bene una storia così così o inventare una storia bellissima scrivendola male… Ma scrivere bene non significa fare i narcisi per specchiarsi in ogni pagina: lo scrittore deve saper scomparire. Solo così gli accordi diventano la musica di cui parlavi, altrimenti l’armonia viene sacrificata al virtuosismo.
Parli di Tolkien come esempio di grandezza stilistica… ma il punto è proprio questo: nelle storie come Il Signore degli Anelli ti ci puoi immergere e dimenticare che dietro tutte quelle parole una in fila all’altra c’è un autore che le ha messe insieme. Con scrittori come lui, la purezza della forma risuona senza salire sul palcoscenico, è… come dire… un’orchestra che suona Rhapsody in Blue mentre Gary Cooper prende per mano Barbara Stanwyck, ma la musica che riempie la scena è in sottofondo e tu aspetti soltanto che lui baci lei. Punto. Lo stile raffinato di Tolkien rende la storia più credibile, certo, ma non ti soffermi a dire “mamma santa, quanto scrive bene!”, perché l’unica cosa che vuoi è andare avanti nell’avventura insieme a Frodo & C.
Insomma, come diceva Nils Liedholm, la padronanza dei fondamentali è necessaria, ma te lo ricordi Chiarugi? Era un fenomeno del dribbling, però finiva quasi sempre per attorcigliarsi su se stesso e perdeva la palla. Per restare nell’allegoria calcistica, Totti è stilisticamente eccellente, ma più di tanti altri fenomeni ha proprio quel “lampo creativo” che gli consente di stare una spanna sopra gli altri e fare della sua squadra uno squadrone.
Gabriele
mercoledì 4 giugno 2008
È estate, Mapang! (15)
Il rumore del motore, generalmente insopportabile all’interno del blindato, era fortunatamente attutito dai crediti ammassati nell’abitacolo, così non c’era bisogno di coprirsi le orecchie con le cuffie isolanti. Dopo cinque minuti, mentre il veicolo sobbalzava sorpassando le macerie di un banca, Mapang provò a chiedere a Zivelianna perché si fosse offesa: «Scusa, Zive, ma se io rido di te non è la stessa cosa di te che ridi di me?».
«Non capisci: è ovvio che è diverso».
«Ma perché è diverso?».
Zivelianna lo guardò scuotendo la testa: «Quando riuscirai a capire le donne sarà sempre troppo tardi, Ciccio».
Mapang sorrise: «Era tanto che non mi chiamavi “Ciccio”…».
«Non ti ho chiamato Ciccio».
«Sì che mi hai chiamato Ciccio».
«Sei noioso».
«Ma…».
«E sei irrecuperabile. Quindi non ti posso aver chiamato Ciccio».
«Ok. Ci rinuncio».
«Ah, ecco, lo vedi? Non te ne importa niente, di me!».
«Brutta storia…» mormorò Mapang stringendo le mani sul volante.
«Come mi hai chiamata? Come hai osato chiamarmi?».
«Io? Ma che…».
«Ti ho sentito benissimo, cafone! Tutti uguali, gli uomini: appena fanno due soldi, pensano di potersi permettere tutto. Ritira subito o sono affari tuoi!».
«Ho detto “brutta storia”, cosa…».
«Hai detto la parolaccia che fa rima con “boia”! Non ti azzardare a negarlo!».
«Oh, io non ho detto niente del genere, va bene? Comunque sia… senti, Zive, facciamola finita, vuoi? Ti chiedo scusa e chiudiamola qui».
«Ah, lo ammetti allora, bastardo di un romano! E io, ingenua, che quasi quasi credevo di aver sentito male!».
Fu allora che Mapang, mettendosi le mani in testa per non sbatterla sull’acciaio dell’abitacolo, lasciò il volante. Dopo qualche secondo il blindato s’infilava a capofitto nelle scale della metropolitana, andando a sradicare i tornelli all’entrata dei binari. E lì si fermò.
Anche il cappotto nero, che già scendeva il primo gradino con un sorriso che scopriva i denti gialli, fece un passo indietro sentendo l’ululato di Mapang.
(fine della quindicesima puntata)
«Non capisci: è ovvio che è diverso».
«Ma perché è diverso?».
Zivelianna lo guardò scuotendo la testa: «Quando riuscirai a capire le donne sarà sempre troppo tardi, Ciccio».
Mapang sorrise: «Era tanto che non mi chiamavi “Ciccio”…».
«Non ti ho chiamato Ciccio».
«Sì che mi hai chiamato Ciccio».
«Sei noioso».
«Ma…».
«E sei irrecuperabile. Quindi non ti posso aver chiamato Ciccio».
«Ok. Ci rinuncio».
«Ah, ecco, lo vedi? Non te ne importa niente, di me!».
«Brutta storia…» mormorò Mapang stringendo le mani sul volante.
«Come mi hai chiamata? Come hai osato chiamarmi?».
«Io? Ma che…».
«Ti ho sentito benissimo, cafone! Tutti uguali, gli uomini: appena fanno due soldi, pensano di potersi permettere tutto. Ritira subito o sono affari tuoi!».
«Ho detto “brutta storia”, cosa…».
«Hai detto la parolaccia che fa rima con “boia”! Non ti azzardare a negarlo!».
«Oh, io non ho detto niente del genere, va bene? Comunque sia… senti, Zive, facciamola finita, vuoi? Ti chiedo scusa e chiudiamola qui».
«Ah, lo ammetti allora, bastardo di un romano! E io, ingenua, che quasi quasi credevo di aver sentito male!».
Fu allora che Mapang, mettendosi le mani in testa per non sbatterla sull’acciaio dell’abitacolo, lasciò il volante. Dopo qualche secondo il blindato s’infilava a capofitto nelle scale della metropolitana, andando a sradicare i tornelli all’entrata dei binari. E lì si fermò.
Anche il cappotto nero, che già scendeva il primo gradino con un sorriso che scopriva i denti gialli, fece un passo indietro sentendo l’ululato di Mapang.
(fine della quindicesima puntata)
Iscriviti a:
Post (Atom)