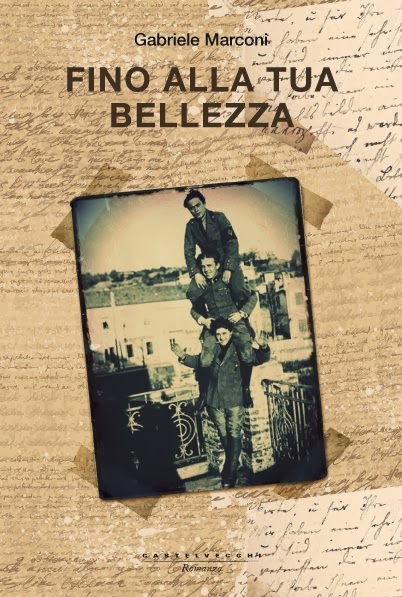Mapang non aveva mai corso tanto in vita sua.
Prima gli ultrabufali, poi quei mentecatti dei neopunk… Alla fine, pensando di aver messo abbastanza metri tra lui e le zecche-sonanti, come li chiamava Zivelianna, vide i vagoni della metro con le porte che si stavano per chiudere e ci s’infilò con un salto, fermandosi poi a fare ciao-ciao con la manina dal finestrino chiuso. Purtroppo per lui, una vecchia decise di farsi aiutare dal controllore proprio in quel momento, e le porte si riaprirono per qualche secondo: giusto in tempo per far sì che i neopunk arrivassero a valanga, seppellendo la vecchina, il controllore e Mapang, immobile al centro del vagone a smadonnare contro la sfiga.
Nessuno pensò di avvertire il conducente, e così la metro ripartì con la massa informe che si agitava sopra i tre sventurati. La vecchia, spiattellata sotto a tutti, non si muoveva più e il controllore vomitava addosso a Mapang, che, ad occhi chiusi per lo schifo, cercava di ripararsi da cazzotti e calci menati a casaccio dai neopunk. All’improvviso la pressione e i cazzotti finirono. Un istante era l’inferno, l’istante dopo, semplicemente, la pace totale (se in pace si può dire uno con naso sanguinante, labbro gonfio e tutto il resto imbrattato di vomito di controllore). In ogni caso, una piacevole nebbiolina fresca diede sollievo immediato alla faccia martoriata di Mapang, che la respirò avidamente, sentendosi immediatamente meglio. Decisamente meglio. Quasi euforico.
Cautamente si tirò su in ginocchio, aprì prima l’occhio destro e poi cercò di aprire il sinistro senza riuscirci… ma quello che vide col destro era più che sufficiente: neopunk, controllore e vecchina si erano volatilizzati, e sopra di lui ora torreggiava un uomo coperto da un grande cappotto nero e la faccia nascosta nel cappuccio. In mano, il cappotto-nero stringeva un nebulizzatore coreano: immediatamente l’euforia data dalla "piacevole nebbiolina" venne sostituita da una consapevolezza orrenda… «Oh merda! Mi sono fatto di neopunk nebulizzati!».
Malgrado tutto ancora euforico, Mapang stava cercando di capire se vomitare o no, quando il cappotto-nero gli puntò contro il nebulizzatore e parlò come se si fosse morso la lingua a sangue: «MVERMUE, MTI HO MRISPUARMIATWO PER GUARDARMTI IN FACCIUA MEMNTRWE MWORUI!».
«Come? Scusa, ma proprio non…».
Il cappotto-nero trafficò con un aggeggio che portava sul collo, e dopo qualche sibilo la sua voce uscì da un artoparlantino che portava al petto, gracchiante ma chiara: «Verme! Ti ho risparmiato per guardarti in faccia mentre muori!».
Bennng!
Il rumore della martellata sulla testa del cappotto-nero risuonò nel vagone come una campana del mattino. Quello, riassestandosi il cappuccio che gli era calato un po’ scoprendo una faccia cerosa, si girò lentamente verso Zivelianna, che se ne stava là, a bocca aperta, a guardare il martello con la punta sformata. Il cappotto-nero puntò il nebulizzatore sulla ragazza, ma prima di fare alcunché crollò al suolo con un mugolio soffocato. «Le palle!» gridò Mapang massaggiandosi il piede indolenzito per il colpo, «sulla testa non sentono niente. Non chiedermi perché, ma l’unico punto debole sono i coglioni… o quel che hanno là sotto. Andiamo!». Il treno aveva finalmente frenato e aveva aperto le porte alla fermata ‘Zaerbe. Mapang e Zivelianna schizzarono fuori rullando i primi passeggeri che cercavano di entrare.
Una volta in strada e sicuri di non essere più inseguiti, Mapang cercò di abbracciare Zivelianna. «Zive! Io non… non ci speravo più, di vederti. Ti…».
La ragazza gli diede uno spintone, allontanandolo: «Non ti azzardare a toccarmi, bastardo ingrato!».
«Zive…».
«T’ho aiutato solo perché mi sei passato davanti e ho visto il tipo che ti stava dietro… Bravo, bel furbo!» disse scuotendo la testa. «Se non c’ero io…».
Mapang vide le guance arrossate della ragazza e s’infilò nel varco come un coltello nel burro. Fece la faccia desolata (non che gli ci volesse molto) e allargò le braccia: «Ma io lo so che non dovevo dirti quella cosa, solo che non ero mai stato inseguito da due ultrabufali, prima. Dài, lo sai che sto male se stai male tu».
Lei abbassò la testa e raspò i piedi sull’asfalto. «Un signore è un signore anche davanti all’inferno» disse, ma la grinta era già scesa di tono. Dopo qualche istante di sospensione, Zivelianna alzò gli occhi e abbozzò un sorriso: «Davvero sei stato male?».
Mapang stava per abbracciarla, quando sopra le loro teste si sentì un frastuono assordante: due Agusta-Elefante con gli stemmi della Federazione sfioravano i tetti volando in direzione dell’Arena. Solo allora si accorsero che il cielo sopra l’antico stadio, a un paio di chilometri da loro, era tutto nero per il fumo che si levava da basso. Gli Elefante arrivarono sopra l’Arena e si fermarono in stallo, con le eliche che li tenevano immobili a mezz’aria come abnormi calabroni. Poi cominciarono a sparare con cannoncini e mitragliatrici.
(fine della quinta puntata)
Prima gli ultrabufali, poi quei mentecatti dei neopunk… Alla fine, pensando di aver messo abbastanza metri tra lui e le zecche-sonanti, come li chiamava Zivelianna, vide i vagoni della metro con le porte che si stavano per chiudere e ci s’infilò con un salto, fermandosi poi a fare ciao-ciao con la manina dal finestrino chiuso. Purtroppo per lui, una vecchia decise di farsi aiutare dal controllore proprio in quel momento, e le porte si riaprirono per qualche secondo: giusto in tempo per far sì che i neopunk arrivassero a valanga, seppellendo la vecchina, il controllore e Mapang, immobile al centro del vagone a smadonnare contro la sfiga.
Nessuno pensò di avvertire il conducente, e così la metro ripartì con la massa informe che si agitava sopra i tre sventurati. La vecchia, spiattellata sotto a tutti, non si muoveva più e il controllore vomitava addosso a Mapang, che, ad occhi chiusi per lo schifo, cercava di ripararsi da cazzotti e calci menati a casaccio dai neopunk. All’improvviso la pressione e i cazzotti finirono. Un istante era l’inferno, l’istante dopo, semplicemente, la pace totale (se in pace si può dire uno con naso sanguinante, labbro gonfio e tutto il resto imbrattato di vomito di controllore). In ogni caso, una piacevole nebbiolina fresca diede sollievo immediato alla faccia martoriata di Mapang, che la respirò avidamente, sentendosi immediatamente meglio. Decisamente meglio. Quasi euforico.
Cautamente si tirò su in ginocchio, aprì prima l’occhio destro e poi cercò di aprire il sinistro senza riuscirci… ma quello che vide col destro era più che sufficiente: neopunk, controllore e vecchina si erano volatilizzati, e sopra di lui ora torreggiava un uomo coperto da un grande cappotto nero e la faccia nascosta nel cappuccio. In mano, il cappotto-nero stringeva un nebulizzatore coreano: immediatamente l’euforia data dalla "piacevole nebbiolina" venne sostituita da una consapevolezza orrenda… «Oh merda! Mi sono fatto di neopunk nebulizzati!».
Malgrado tutto ancora euforico, Mapang stava cercando di capire se vomitare o no, quando il cappotto-nero gli puntò contro il nebulizzatore e parlò come se si fosse morso la lingua a sangue: «MVERMUE, MTI HO MRISPUARMIATWO PER GUARDARMTI IN FACCIUA MEMNTRWE MWORUI!».
«Come? Scusa, ma proprio non…».
Il cappotto-nero trafficò con un aggeggio che portava sul collo, e dopo qualche sibilo la sua voce uscì da un artoparlantino che portava al petto, gracchiante ma chiara: «Verme! Ti ho risparmiato per guardarti in faccia mentre muori!».
Bennng!
Il rumore della martellata sulla testa del cappotto-nero risuonò nel vagone come una campana del mattino. Quello, riassestandosi il cappuccio che gli era calato un po’ scoprendo una faccia cerosa, si girò lentamente verso Zivelianna, che se ne stava là, a bocca aperta, a guardare il martello con la punta sformata. Il cappotto-nero puntò il nebulizzatore sulla ragazza, ma prima di fare alcunché crollò al suolo con un mugolio soffocato. «Le palle!» gridò Mapang massaggiandosi il piede indolenzito per il colpo, «sulla testa non sentono niente. Non chiedermi perché, ma l’unico punto debole sono i coglioni… o quel che hanno là sotto. Andiamo!». Il treno aveva finalmente frenato e aveva aperto le porte alla fermata ‘Zaerbe. Mapang e Zivelianna schizzarono fuori rullando i primi passeggeri che cercavano di entrare.
Una volta in strada e sicuri di non essere più inseguiti, Mapang cercò di abbracciare Zivelianna. «Zive! Io non… non ci speravo più, di vederti. Ti…».
La ragazza gli diede uno spintone, allontanandolo: «Non ti azzardare a toccarmi, bastardo ingrato!».
«Zive…».
«T’ho aiutato solo perché mi sei passato davanti e ho visto il tipo che ti stava dietro… Bravo, bel furbo!» disse scuotendo la testa. «Se non c’ero io…».
Mapang vide le guance arrossate della ragazza e s’infilò nel varco come un coltello nel burro. Fece la faccia desolata (non che gli ci volesse molto) e allargò le braccia: «Ma io lo so che non dovevo dirti quella cosa, solo che non ero mai stato inseguito da due ultrabufali, prima. Dài, lo sai che sto male se stai male tu».
Lei abbassò la testa e raspò i piedi sull’asfalto. «Un signore è un signore anche davanti all’inferno» disse, ma la grinta era già scesa di tono. Dopo qualche istante di sospensione, Zivelianna alzò gli occhi e abbozzò un sorriso: «Davvero sei stato male?».
Mapang stava per abbracciarla, quando sopra le loro teste si sentì un frastuono assordante: due Agusta-Elefante con gli stemmi della Federazione sfioravano i tetti volando in direzione dell’Arena. Solo allora si accorsero che il cielo sopra l’antico stadio, a un paio di chilometri da loro, era tutto nero per il fumo che si levava da basso. Gli Elefante arrivarono sopra l’Arena e si fermarono in stallo, con le eliche che li tenevano immobili a mezz’aria come abnormi calabroni. Poi cominciarono a sparare con cannoncini e mitragliatrici.
(fine della quinta puntata)